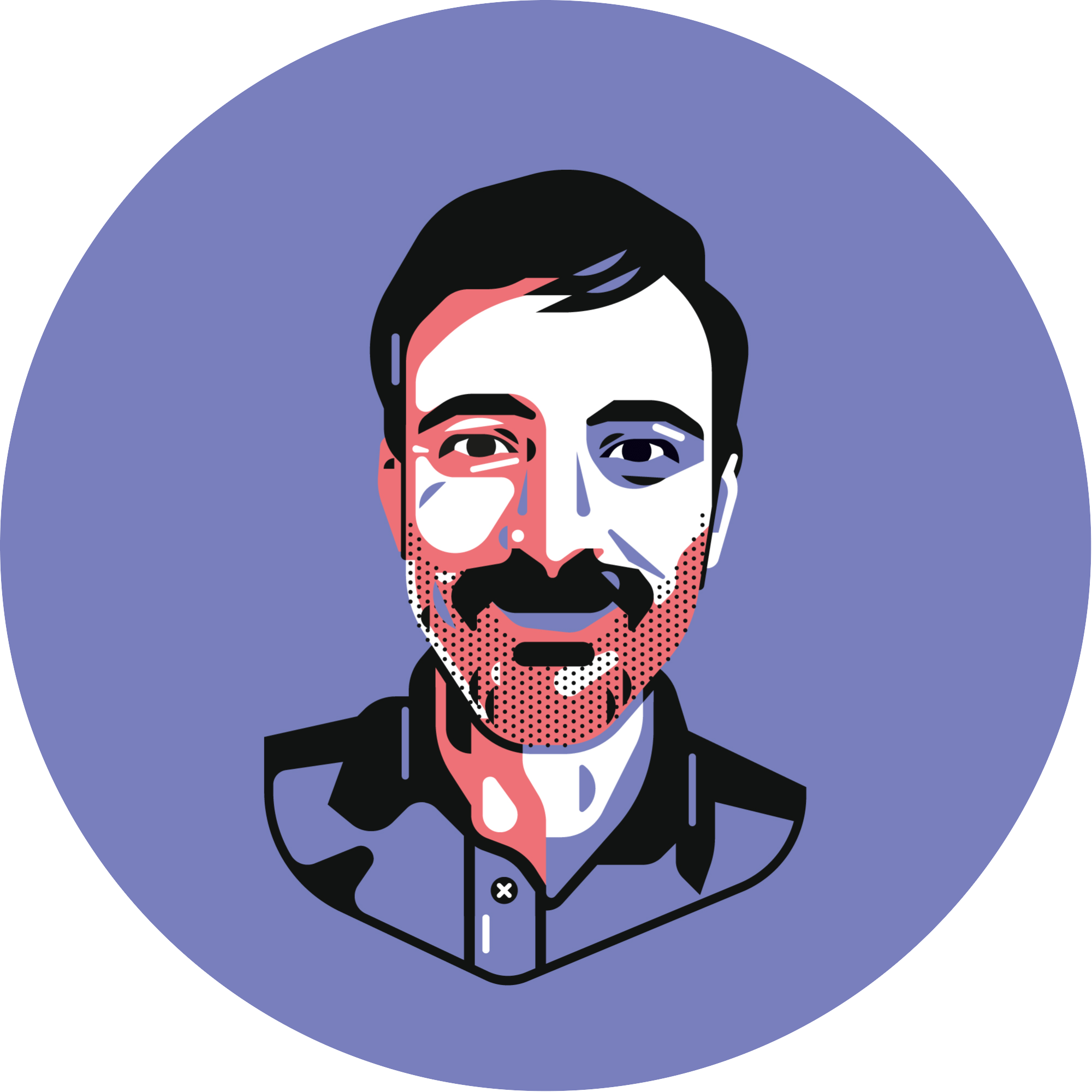Bolognina, oggi
personal, ongoing
È un progetto nato semplicemente per “costringermi” a uscire e fare qualche chilometro a piedi per il quartiere.
Non ci sono velleità artistiche. Non sono un fotografo. L’unico intento è documentare, adottando al contempo sia lo sguardo di chi il quartiere lo abita, sia quello di chi cerca di esplorarlo come lo vedesse per la prima volta.
Le immagini qui raccolte non sono in ordine cronologico ma raggruppate per zona. I testi, sempre relativi al quartiere, sono frammenti presi dal mio profilo Facebook e da altri miei scritti.

8 febbraio 2018
Fu poco meno di 15 anni fa. All’epoca abitavamo in via Niccolò dall’Arca, Bolognina. Io ed Ethel stavamo insieme da poco, e condividevamo l’appartamento con altri quattro. Decidemmo di avere un gatto e andammo al gattile di via Gobetti. Un signore ci fece vedere una gatta bianca. Aveva il pelo lungo, era bella, un po’ altezzosa. Se ne stava lì tranquilla a farsi guardare.
«Questa è una gatta da casa», disse il signore. «Perfetta per una famiglia».
Ma noi, noi — boh, eravamo in sei, col lavandino sempre pieno di piatti da lavare, le cimici rosse, l’unico bagno sempre occupato, i mozziconi delle canne, i calzini spaiati in cucina, il soppalco Ikea di seconda mano — non eravamo una famiglia. E quindi il signore ci portò da un acciaccato piccoletto nero nero, tutto spettinato, gli occhi gialli, di cui uno tumefatto, qualche ciuffo di pelo che mancava. Quando aprì la gabbia e lo prese per la collottola scappò via, saltò sulle braccia di Ethel, da lì sulla spalla di Luca, attaccandosi con gli artigli, e da lì, ancora, sulla mia testa, dove rimase impigliato e ci volle un po’ per toglierlo.
Volevamo lui, ovviamente.
Lo portammo a casa e fece la pipì ovunque. Ci sedemmo per scegliere il nome. A me piaceva Franco. Il ragazzo Catalano che all’epoca era ospite in casa, Carles, che era a Bologna per scrivere un romanzo, disse che se l’avessimo chiamato Franco, come Francisco Franco, ci sarebbe rimasto molto male.
Lo chiamammo Otto, perché era nero come la palla numero 8.
Otto aveva la micosi. Otto era stato picchiato da dei ragazzini in zona Pilastro. Abitava lì, prima di finire al gattile. Decisi che al Pilastro non sarei mai andato a vivere.
Otto girava per casa. Dormiva un po’ in una stanza, un po’ nell’altra. Vide persone che traslocavano altrove e altre che arrivavano. Quando decidemmo di fare la seduta spiritica, lui se ne stette a dormire tutto il tempo: se ne fregava dello spirito di Quinto — un altro numero come lui — che vagava per l’appartamento.
La notte della street rave parade c’era gente ovunque, sotto casa. Il fiume umano passava di lì. Qualcuno si addormentò nel giardino del palazzo. Non c’era nessuno in casa nostra. Qualcuno al rave, qualcuno altrove, io ed Ethel a vedere un film in piazza maggiore. Mi pare fosse 2001: Odissea nello spazio. Quando tornammo a casa Otto non c’era. Lo cercammo ovunque, persino negli armadi. Andammo a dormire preoccupati. Quella notte dormii con l’angoscia sotto al cuscino. Sognai che cadeva di sotto. Eravamo al quinto piano. Quinto, come lo spirito. La mattina dopo Otto non si vedeva ancora. Frugammo di nuovo per tutta la casa ma sembrava sparito nel nulla. Scesi in strada, mi affacciai nel giardino del palazzo, che era pieno di rifiuti, i resti della street parade. Sotto una siepe c’era una macchia nera. Era davvero caduto giù. Cinque piani. Infilai le mani per prenderlo, mi graffiò. Ci riprovai, mi graffiò. Quando riuscii a prenderlo vidi che una zampa penzolava giù. Usciva sangue. Corsi in casa con lui in braccio. Avevo una camicia hawaiana, sporca di sangue.
Corremmo dal primo veterinario libero che trovammo, che curò la ferita e disse che le ossa della zampa si sarebbero aggiustate da sole. E così fu, dopo qualche mese di zoppicamenti. Un po’ zoppo lo rimase sempre, e quando saltava ora faceva uno strano verso, un “prrrrrr” che diventò il “prrrrrr” di Otto.
Quando io ed Ethel cambiammo casa venne con noi. Da sei a due, niente più cimici né piatti sporchi, niente più casino a tutte le ore, niente più Bolognina. Andammo in centro. Monolocale, secondo piano.
Il soppalco Ikea di seconda mano ci seguì, e di notte Otto veniva a dormire lassù, da noi. Sentivamo “prrrrrrr” e in due salti era in fondo al letto. Ogni tanto ci attaccava i piedi mentre dormivamo. Una volta lo fece e io, d’istinto, gli diedi un calcio e lo buttai giù. Quando la sera si accoccolava accanto a noi sul divano — l’unico momento della giornata in cui ci permetteva di coccolarlo senza riempirci di graffi e morsi — certe volte pensavo che se gli fosse successo qualcosa, se fosse morto, ne sarei rimasto distrutto. Solo l’idea, ed ecco che avevo gli occhi lucidi.
Si ammalò mille volte, Otto. Micosi, raffreddore (scoprimmo che si poteva fare l’aerosol anche ai gatti, affittammo persino la macchinetta), infezioni varie, medicine, medicine, medicine. Una volta, per fargli prendere una pillola, dopo averle provate tutte — dal nasconderla in mezzo alla carne al polverizzarla e spalmarla sulla zampa col burro in modo da fargliela leccare — lo afferrammo in due con una coperta, costringendolo a forza, piangendo come due bimbetti mentre gli allargavamo la bocca. Quella volta gli rompemmo un dente. Lo sputò lì, per terra. Ci buttammo sul divano ridendo e piangendo allo stesso momento.
Poi arrivò Sveva. Quando Ethel era incinta di qualche mese cominciammo a cercare un’altra casa. Parlammo alla nostra veterinaria di nostra figlia in arrivo. Ci disse che Otto, per via del suo carattere, conseguenza del suo passato — dannati ragazzini del Pilastro —, non era molto adatto a stare coi bimbi. Ci pensammo un po’ su. Eravamo stressati per la casa da trovare, impauriti per la nascita di una figlia, stanchi per il doppio lavoro che all’epoca facevamo: il giorno in un ufficio, la notte Frizzifrizzi. Una sera chiamai l’ambulanza perché ero convinto di avere un infarto. Il paramedico era un ragazzo dallo sguardo dolce. Dopo avermi controllato mi chiese se c’erano motivi di stress. Gli raccontai un po’, mi rassicurò e mi strinse la spalla.
Alla fine chiedemmo ai miei genitori di adottare Otto. Loro avevano sempre avuto gatti, avevano il giardino e soprattutto la pazienza. Mi sentii in colpa. In colpa per aver abbandonato una creatura che amavo. In colpa perché ora l’amore per Otto mi sembrava la versione economica dell’amore che ancora non capivo del tutto ma che sapevo di tenere in serbo per la figlia che stavo per avere.
Questo succedeva nel 2008. Otto, bolognese del Pilastro e poi della Bolognina, diventò marchigiano, anzi monsanese. Dopo Sveva nacque Saba, e intanto Otto invecchiava, aveva problemi ai reni, vomitava, un altro raffreddore, altri acciacchi. Riusciva a mangiare quasi solo crocchette, costosissime. L’estate scorsa era arruffato come il giorno in cui lo portammo a casa dal gattile. Sembrava stesse perdendo la vista. Diabete. Come mia nonna. Prima gli occhi poi tutto il resto. Qualche giorno fa mia madre ha portato Otto dal veterinario. L’hanno attaccato a una flebo. Oggi lei mi ha chiamato, dicendo che Otto, che si sarebbe potuto chiamare Franco — Otto del Pilastro e della Bolognina, Otto del quinto piano, Otto che faceva prrrrrr —, non sarebbe più tornato a casa.




21 novembre 2016
Dopo la presentazione e un paio di birrette mi dirigo verso casa. Prendo al volo un rotolino di qualcosa, 2€, arrivo alla fermata che ancora mi sto togliendo le molliche col tovagliolino e vedo che il prossimo 27 sarebbe passato dopo 17 minuti. Mi faccio un trancio di pizza, 1,40€. Accanto a me, davanti al bancone, c'è un ragazzo che canticchia un motivo arabo. Quello dietro al bancone è un suo amico. Il tempo di scaldare il trancio e tutti e due ridacchiano leggendo un volantino che pubblicizza hamburger indiani.
Inaspettatamente il 27 arriva appena esco dal posto. Finisco la pizza in autobus dove una bionda dell'est con le guance rosse, tra una limonata e l'altra con un ragazzo magrebino altissimo, è totalmente presa dalla ruolo "tipa del gangsta" e fa la bulla con due ragazze giapponesi chiedendo platealmente «vuoi droga? vuoi droga?».
Alla mia fermata non c'è nessuno. Il trancio di pizza è finito e ho il tovagliolino appallottolato in tasca. Decido di farmi un caffè e fumare una sigaretta prima di entrare in casa.
L'unico bar aperto a portata di sguardo è quello degli africani. Quello è stato il primo bar in cui sono andato una volta arrivato qua nel quartiere, 7 anni fa. In 7 anni ha cambiato altrettante gestioni. Ora c'è un barista africano ed è sempre pieno.
Provo ad aprire la porta ma non riesco a entrare perché il passaggio è bloccato da un culo. Il culo, dopo una rapida occhiata in giro (non che ci voglia molto, saranno 3mq davanti al bancone e uno dietro), è di un signore che vedo sempre in giro, negli altri bar, a fare la spesa, a comprare la frutta. Ha la faccia da ex carabiniere. E quel poco che so di lui è che è stato davvero un carabiniere, o un finanziere. Quando mi incrocia per strada talvolta mi saluta e talvolta no. Io lo stesso. Dire che ci stiamo simpatici, così, a vista, forse è azzardato, ma ci andiamo vicino. E comunque c'è il suo culo davanti alla porta. Un culo ballerino. Sta infatti agitando i fianchi alla grande e davanti a lui c'è il culo di una ragazza africana, che si agita pure lei. Davanti alla ragazza africana c'è il culo di un altro ragazzo africano e poi, finalmente, il bancone.
Mi infilo nella fessura della porta e un altro ragazzo africano mi dà il cinque e mi dice «vai, vai, vai al bancone». Ma non ce la faccio, io a raggiungere il bancone.
Da sinistra spunta un altro ragazzo, con gli occhi a fessura. Mi dà il cinque pure lui.«Gadblessiu», dice sorridendo. E ancora «Blessblessblessiu».
Nel frattempo il trio danzereccio si accorge di me e mi fa passare.
In tv passano video di rap nigeriano. Il barista, che balla pure lui, ma da solo, non mi ha ancora visto.
Il primo tizio, quello del cinque, urla «un clienteeee». Accanto a lui, seduta, c'è una ragazza col faccione che mi fissa.
Chiedo un caffè «ma se ha già spento la macchinetta non fa niente».
Il barista guarda la macchinetta e con una certa sorpresa vede che è accesa.
«Si vede che aspettava proprio te», dice. Intanto i tre hanno ripreso a ballare.
Bicchierino d'acqua, come si usa qua a Bologna, e il tempo che la tazzina calda risuoni nel piattino, da uno stanzino che non avevo notato spunta un altro uomo. Occhi a fessura pure lui. Molto più dell'altro. È praticamente a occhi chiusi.
Faticando un po' per passare tra me e i ballerini, va a sedersi accanto a ragazza-faccione, che non ha mai smesso di fissarmi.
«Bevi solo il caffè?», mi chiede lui. Faccio cenno di sì.
«È il mio compleanno», mi dice, alzando una delle bottiglie che ha davanti. Gli altri intanto ballano. L'ex carabiniere è ubriachissimo e si sta divertendo un mondo, in giacca e cravatta, le basette vagamente spettinate.
«Tanti auguri», dico al ragazzo. «Fa' come se avessi bevuto, mi sono già fatto un paio di birre, sono stanco, ho due bimbe a casa e devo svegliarmi presto».
La ragazza-faccione, sempre senza spostarmi gli occhi di dosso, comincia allora a fare su e giù con la testa.
«Ben detto amico», dice. E dà una gomitata a occhi a fessura. «Ben detto».
Pago e vado. Mentre esco i tre ancora ballano, il barista torna ai suoi video, due non ho idea di dove siano finiti e ragazza-faccione, seduta accanto a occhi a fessura fa ancora su e giù con la testa ripetendo «Ben detto».
L'ultima cosa che sento è un ultimo «Gadblessiu».




19 luglio 2017
Sul 27 un trio di pre-adolescenti problematici vaga nella notte in cerca di qualcosa da mangiare e se la ride beatamente, cercando di farsi il ponte Matteotti e la Bolognina “senza mani”. Mica facile, visto che notoriamente, dopo il ponte, gli autisti accelerano ed è dura restare in piedi senza attaccarsi a qualcosa.
Io sono lì accanto e me la rido seguendo le loro idiozie e sto pronto a raccattarne uno casomai volasse via.
Capiscono che li sto osservando e ascoltando e quindi fanno ancora di più gli scemi, io invece capisco che non conoscono benissimo la zona e allora faccio loro da navigatore: qua c'è la buca grossa, occhio che adesso c'è la doppia curva sinistra-destra, qua attraversano alla cazzo e l'autobus potrebbe inchiodare...
I tre fanno finta di niente e continuano a cazzeggiare tra loro ma è evidente che seguono i consigli.
Sono due ragazzini e una ragazzina. Il capo è lei. Uno dei due maschi, invece di cercare di rimanere in equilibrio stando di lato, sta di fronte.
- Così è più difficile, dice
- Mica vero, urla l'altro
- Sì che è vero, intervengo io, pensa ai surfisti, agli skater...
Non è convinto, ci prova, quasi rotola per terra, gli altri due lo insultano, spietati.
Lui mi guarda e arrossisce. Si mette a studiare i miei tatuaggi anni '90. Gli piace quello sulla mano.
- Quanto l'hai pagato?, chiede
- C'erano le lire.
Ci meditano un po' su, poi quello che quasi cadeva mi racconta che ha provato a farsene uno con lametta e inchiostro.
La ragazza mi chiede quanti anni ho.
- 38
- Cazzo!, fa lei.
Indeciso se la sua sorpresa fosse relativa al fatto di portarli splendidamente o semplicemente perché i miei 38 anni, per loro, equivalgono a un settantenne per me, li saluto e mi preparo alla discesa, stando di lato, come un surfista, senza mani.








15 aprile 2015
Il mio telefono — che, bastardo, mi osserva, mi ascolta e mi controlla — dice che negli ultimi 3gg ho fatto 55km a piedi.
Il brutto è che non sto andando a Santiago De Compostela né a cercare i funghetti magici tra i boschi. Il brutto.
Ma il bello è che oggi i miei studenti (responsabili di una piccola parte di quei 55km) mi hanno fatto vedere una Treviso che non conoscevo e alla fine ci siamo seduti tutti su una panchina circolare a raccontare gli appunti che avevamo preso per la strada, con la gente che guardava “la strana gita” come a dire “e questi che fanno, questi che vogliono?”. Il bello.
Poi la Bolognina, che a quanto pare oggi è piena di matti. Furgoncini che caricano gente in corsa, uno che passa in mezzo alle macchine in bici gridando estasiato “cocaina!”, un gigantesco mediorientale che per ridere sbatte l'amico contro il bus, uno ubriachissimo che si è fermato in mezzo alla strada a braccia aperte a urlare ciao alla polizia, che poi però è andata via a fermare un'altra macchina.
La Bolognina.







15 agosto 2015
La grande novità dell'estate 2015 sono state le mantidi religiose. Qua in giardino non sono sbarcati immigrati né abbiamo trovato sedicenni fatti di ecstasy. Nessuno ha mai nominato la Merkel, nemmeno il gatto, che pure si chiama Otto — ma effettivamente avrebbe dovuto chiamarsi Bruno, e prima ancora Franco ma il ragazzo catalano che abitava con noi nell’appartamento da sei in Bolognina all’epoca in cui andammo a prendere Franco/Bruno/Otto al gattile (ma giurerei che ce lo presentarono con un altro nome), beh il ragazzo catalano, che con omissis/Franco/Bruno/Otto avrebbe dovuto vivere qualche mese, ce lo chiese proprio di non chiamarlo Franco, e dunque, scartato Franco, rimase omissis/Bruno/Otto, ma solo per qualche istante, perché quando lo vedemmo, piccolo e nero e tutto acciaccato, con la psoriasi, un occhio pesto, le croste per i tagli che qualche ragazzino figliodiputtana gli fece prima di essere trovato, quando lo vedemmo e mi saltò in testa, proprio sopra, sui capelli, attaccato con le unghiette, lì capimmo che lui era Otto: Otto nell'appartamento da Sei al Quinto piano (Quinto poi ritorna come numero perché la sera che facemmo la seduta spiritica — ma lo spagnolo se n’era già andato — evocammo un certo Quinto, sedicenne romano morto nel ’14 per l’influenza Spagnola, e non è un caso perché di sicuro Quinto l’abbiamo creato noi, seduta stante, quella stessa sera, senza rendercene conto, anche se questa, come si dice, è un’altra storia, che tra l’altro a Otto interessò ben poco perché al contrario di quanto si dice, e cioè che i gatti avvertano la presenza degli spiriti, lui se ne stette beato a dormicchiare e leccarsi il culo per tutto il tempo che noi eravamo alle prese con la tazzina, la tavola con le lettere scritte a pennarello e i pianti di chi era preso malissimo, confermando poi che non di evocazione si trattava ma del parto del nostro inconscio colletivo).
Numerologia e spiritismo a parte, messa in standby la crisi greca, ritrovandoci sia senza droghe che senza sedicenni e al netto di qualche dibattito sulla Grande Grandinata di Ferragosto (quale dei mille meteo consultati ci ha indovinato?), gli gnocchi col sugo alla papera della Festa dell’Assunta (si potranno congelare?), i rimedi contro la diarrea (tè o camomilla a piccoli sorsi), le stelle cadenti che finalmente sono cadute — rapide come missili ma ancora magiche — pure nella vita di mia figlia (l’anno scorso sai che pianto quando fu l’unica a non vederle, e sì che le avevo spiegato come fare: guarda un punto, al centro del cielo, ma non guardarlo davvero) alla fine sono dunque arrivate le mantidi. Che abbiamo subito cercato su Wikipedia, per documentarci, e che di giorno se ne stanno nascoste chissà dove e di notte amano attaccarsi sulla zanzariera. Ma soltanto quando stiamo fuori a chiacchierare, sennò non si vedono. Tipo adesso, che qua già tutti dormono e sono seduto da solo, davanti alla pozzanghera perenne e accanto al gatto che russa: di mantidi nemmeno l’ombra.











25 giugno 2019
(contro lo sgombero di XM24)
Siamoci.
Io ci sarò.
Perché abito in questo quartiere.
Perché lì ho conosciuto la mia dolce metà.
Perché lì ho ascoltato concerti, visto presentazioni di libri, talvolta mi sono semplicemente seduto a leggere davanti a una birra e in mezzo a mille voci.
Perché non ci sono biglietti da pagare. Perché il giovedì c'è CampiAperti ed è pieno di genitori e bambini, tra cui noi.
Perché XM24 è una cosa bella e le cose belle, lo so, non durano, ma bisogna difenderle con tutta la cura e l'amore possibili come e finché se ne ha la possibilità.
Perché c'è sempre bisogno, e ora più che mai, di un luogo vivo e senza biglietti, consumazioni obbligatorie, logiche di potere, mitizzazione dell'efficienza, “si fa tutto con un'app”.
Perché so che se la Bolognina e Bologna tutta perderanno questo luogo sarà l'ennesima vittoria di chi chiude, di chi sbarra, di controlla, di chi sceglie per gli altri, di chi si allinea, e di chi non vorrebbe allinearsi ma alla fine si allinea lo stesso e odia chi non si è allineato perché pure lui/lei non voleva allinearsi però alla fine l'ha fatto.
















3 novembre 2016
Correva l'anno 2002. Bologna la vivevo da pendolare del weekend. All'epoca avevo abbandonato il Dams e facevo il servizio civile nelle Marche. Stavo a casa dei miei e il fine settimana prendevo l'interregionale, dormivo una notte in Bolognina, da Ethel, che avevo conosciuto da poco, e l'indomani tornavo giù.
C'era Radio Città del Capo a tutto volume e a tutte le ore in quell'appartamento sempre pieno di gente. C'erano vecchie coperte da vecchi. C'erano birre sgasate ma non si trovava mai il cavatappi. C'era una bella luce azzurra, la domenica mattina, in cucina. L'odore del caffè o quello del mate delle coinquiline. E un sacco di accendini, pure. Sparpagliati un po' ovunque, come i cd presi in affitto, sempre graffiati, che duplicavamo e riascoltavamo ed erano pieni di salti.





1º settembre 2015
Le nove e mezza di sera. Io ho appena finito di leggere a mia figlia grande delle avventure di Orso Blu dentro al buco dimensionale e salgo di sopra a piegare e sistemare i vestiti rimasti a prendere il sole per tutto il pomeriggio.
Nella camera delle bimbe si spegne la luce. Ethel culla la piccola, che ha otto mesi. In salotto le finestre sono spalancate per far entrare quel poco di aria fresca che gira e a un certo punto sento gridare, sento sbattere, sento gridare ancora, sembra qualcuno che litiga, sembra addirittura qualcuno che stia picchiando qualcun altro.
Scendo e mi affaccio. Pure i vicini sono fuori a vedere, le teste spuntano una a una come in una scena da film ben coreografata.
Decido di andare a vedere. Ancora scale — ché quando Ethel era ancora incinta della prima gravidanza e mi diede mandato di andare a cercare una nuova casa, visto che nel minuscolo monolocale in centro col cavolo che ci saremmo stati in tre, mi disse espressamente di evitare appartamenti con troppe scale e poi finì per scegliere, lei, quello con la scala più ripida mai vista, all’ingresso, e un'altra scala, ma a chiocciola, per raggiungere la nostra camera.
E quindi sono al portone di casa che ascolto per un istante prima di aprire, impugnando la mazza da baseball con una mano. Apro lentamente. Nessun rumore strano, solo chiacchiericcio, qualche tv: il solito. Ripongo la mazza al suo posto e esco. Davanti al cancello, alla fine del cortile, c'è un vero e proprio assembramento. Noto qualche giacca catarifrangente. Penso al peggio. Penso a polizia e ambulanza. Mi immagino uno steso a terra col sangue che “spisciola” fuori.
La cosa strana è che non vedo lampeggianti. Decido di avvicinarmi per capire di che si tratta. Sono in maglietta, calzoncini, ciabatte, e fuori dal cancello c'è gente seduta a terra e c'è gente in piedi e c'è gente pure dall'altra parte della strada, chi appoggiato ai bidoni della spazzatura, chi ad altri cancelli o reti.
Saranno circa una ventina, africani. Con loro un ragazzetto bianco secco secco coi capelli rossicci e una camicia rosso vino. Più isolata, quasi in mezzo alla strada, c'è una ragazza. L’unica ragazza, bianca pure lei, con un paio di shorts.
Vado al cancello. Non mi ha visto ancora nessuno. Intercetto lo sguardo del ragazzino e chiedo «tutto a posto?».
Al che a lui si allargano gli occhi, ha l’aria imbarazzata, ci pensa su un istante e poi si lancia in una lunga spiegazione che ha il sapore della giustificazione. «Sbagliato indirizzo», dice. «Ci avevano detto questa via e questo numero ma doveva esserci un bar però il bar non c'è», dice, mentre il resto del gruppo è quasi completamente voltato verso di me, compresi quelli seduti per terra, con la schiena appoggiata al mio cancello.
«Stanno arrivando a prenderli», dice ancora il rosso. «Mi dispiace per il disturbo», aggiunge.
Io, con gli occhi di tutti addosso, spiego di aver sentito casino, di essermi preoccupato, di esser sceso per quello. Spiego che a Bologna c'è un’altra via con lo stesso nome, forse è là che devono andare.
Il rosso si guarda attorno e dice che no, non sono stati loro a urlare, anche perché l’italiano non lo parlano e la cosa ha senso, visto che io ho sentito urlare in italiano.
Mi giro verso la ragazza, che nel frattempo si è messa a parlare in un inglese rabberciato su con alcuni dei ragazzi africani. Lei sembra più tranquilla di lui.
Non mi viene in mente altro da dire che «va bene, ciao». E me ne vado.
Quando sto per riaprire la porta di casa si affaccia una vicina dal balcone e mi chiede che succede. Le spiego. Mi dice che l’altra via che ha il nome della nostra via è a Borgo Panigale. Mi chiede quando siamo tornati dalla vacanze. Mi dice che fa caldo. E intanto penso a quando lo racconterò a Ethel, una volta su. Che ormai quando risalgo dopo una sigaretta, la sera, mi piglia in giro sui miei strani incontri, tipo quello con la “runner” senza un braccio di qualche settimana prima.
In cima alle scale comincio a pensare che forse potrei portare dell'acqua. Chi non vorrebbe dell’acqua in una calda notte d’estate dopo chissà che viaggio e smarrito per la Bolognina? Ne parlo con Ethel, che ovviamente si mette a ridere e dice già: «pure questa storia qua la scriverai, giusto? Ma non è che te le inventi? Non è che la ragazza senza un braccio l’hai vista solo te e se ora mi affaccio non c’è nessun africano?».
Prendo tutte le bottiglie dell’acqua che abbiamo, ne tolgo una per il biberon della piccola, prendo una pila di bicchieri di carta e vado giù di nuovo.
Sono ancora tutti lì (davvero, lo giuro vostro onore). Stavolta si accorgono di me prima di arrivare al cancello.
«Volete dell’acqua?», chiedo a voce alta. La ragazza urla un grazie. Il gruppo di africani si anima, si alzano, iniziano a prendere le bottiglie, a distribuire i bicchieri, mi fanno cenni di ringraziamento con la testa, mente io comincio a rollarmi una sigaretta e a chiedere al ragazzo coi capelli rossicci di che associazione sono, lui e la ragazza, dando per scontato che lo siano, perché sono giovani, perché sono gli unici due bianchi in un gruppo di venti maschi africani dai quindici (o giù di lì) ai trenta-trentacinque (o giù di lì).
Il rosso si chiama Daniele. «Non siamo di nessuna associazione», dice. «Li abbiamo incontrati a una cabina del telefono e ci hanno chiesto un indirizzo e quindi li abbiamo accompagnati qua».
Lei intanto — una bella ragazza alta che forse è la fidanzata, forse un’amica, forse chissà — chiama quelli rimasti seduti dall’altra parte della strada.
«L’indirizzo che cercate forse è a Borgo Panigale», faccio io. Ma poi per sicurezza provo a cercare il nome del bar in cui sono diretti e vedo che è a due passi da lì.
«Saranno trecento metri», spiego.
Squilla un telefono. È il mio. È Ethel che mi chiama per sapere se vogliono uva. E pane. Perché c'è rimasto poco altro. Pane e uva.
«Volete pane e uva?», chiedo. «L’uva non è molta ma...».
«No no grazie», mi dice il ragazzo, mentre uno degli africani, uno dei più giovani, è evidentemente attratto dalla sigaretta.
«Do you want one?». Lui mi fa sì con la testa e io tiro fuori il tabacco.
«Can you make it by yourself? Do you prefer I roll one for you?».
Non risponde. E io inizio a preparare.
«Where are you from?», chiedo, ma lui niente. Finché un altro, più vecchio di luì, esclama felice: «Eritrea».
Vengono tutti dall'Eritrea.
«Là c'è un dittatore tremendo» interviene nel frattempo Daniele, che è un incrocio tra un Mark Zuckerberg più belloccio e il compagno di banco al liceo, quello più bonaccione e gentile.
Finita di preparare la sigaretta al tipo, gliela passo. Lui sta per accenderla al contrario, dal filtro, e gli altri suoi connazionali lo bloccano giusto in tempo, mettendosi a ridere, prendendolo un po’ per il culo e spiegandogli come si fuma.
Intanto è arrivato il tizio a prenderli, eritreo come loro, immagino.
Daniele va a parlare con lui, gli spiega la situazione.
Il gruppo comincia a muoversi. Una buona parte di loro passa da me per ringraziarmi e stringermi la mano. A uno si rompe una borsa. Hanno tutti una borsa, chi grossi sacchi di tela chi buste della spazzatura, qualcuno uno zaino.
Dico di aspettarmi un momento che recupero una borsa per sostituire quella rotta.
Risalgo, riscendo. Ethel nel frattempo si è messa a guardare un film.
Porto un sacco nero gigante e una grossa shopper di tela. Prendono entrambe e ringraziano di nuovo.
«Good luck», dico a tutti.
Con Daniele ci diamo una pacca sulla spalla. La ragazza la saluto con il mio “ciao ciao con la manina” d’ordinanza.
Quando li lascio e me ne torno alla porta di casa se ne stanno andando.
Un’ora dopo, uscendo di nuovo a fumare, la strada è deserta.














3 ottobre 2017
(da un mio articolo uscito su Frizzifrizzi)
Il cielo, qua in città, è diverso rispetto a quello di campagna sotto al quale sono nato. Meno drammatico, spesso più piatto, il cielo della Bolognina si fa apprezzare in maniera sottile: gioca coi palazzi e le vetrate, si nasconde dietro ad alte facciate grigie per poi rivelarsi appena girato l’angolo, come un bacio inaspettato da qualcuno che non pensavi di trovare proprio lì.
E nelle livide mattinate d’autunno, girando tra casette basse ed edifici post-industriali, mi balza sempre in testa la voce di Morrissey quando canta di cieli vittoriani color ardesia (Come back to Camden, in You Are the Quarry, 2004), che a loro volta mi ricordano la Londra vissuta da ragazzo, un’alba sul tetto di un palazzo, altri cieli, altri pezzetti di vita vissuta sotto a quel soffitto cangiante, a quella cupola che cambia sempre ma è sempre la stessa, per tutti, da prima ancora che l’uomo muovesse i primi passi sulla terra.







6 luglio 2015
Mi chiedo, da quando nel cortiletto degli ultimi arrivati, tra i vicini, sono spuntati fuori da un giorno all'altro dei nanetti da giardino, di vedetta sugli scalini, in fila lungo il fianco delle due auto parcheggiate strette strette lì dentro, mi chiedo quanto influiranno sulla percezione del condominio tutto, ché la gente, per strada, di solito passava e girava la testa come viene naturale fare per vedere un giardino o un cortile, cosa c’è, com’è messo, se c’è un gatto o forse un cane, un bambino che gioca, un’amaca che sa di spiaggia tropicale nel bel mezzo della Bolognina, i fenicotteri come in quella casa a Milano, quante piante, se in vaso o a terra, misurando dal marciapiedi il pollice verde del proprietario, cose così, e invece ora quelli che passano e si voltano talvolta si fermano pure, e non era mai successo e pure se non lo sanno che in quella finestra laggiù in fondo ci sono io, c’è la mia vita, c’è il mio mondo, io lo so che loro passano e si fermano e vedono i nanetti e poi guardano su e là ci sono io.
Ché quando sono nei giardini degli altri, i nanetti, ti vien da annuire con rassegnazione, persino da sorridere, ma quando arrivano a un salto di sguardo dalla tua finestra i nanetti portano una strana energia, e ti chiedi se svalutino l’immobile, se si possa pagare meno Tasi e Tari se provi che il vicino ha messo i nanetti, se attirino o dissuadano i furti in appartamento i vari Dotto, Mammolo, Pisolo e Piainculolo...












11 settembre 2020
(da un mio articolo uscito su Frizzifrizzi)
È dal 1985 che la Bolognina non è più un quartiere. Come succede con le banche e le grandi aziende, è arrivata una fusione a semplificare e concentrare, unendo parte della zona nord-ovest di Bologna in un’unica, grande circoscrizione chiamata Navile.
Celebre anche al di fuori dei confini cittadini per la storica svolta con cui Achille Occhetto trasformò il PCI in PDS, la Bolognina, ormai soltanto un rione, viene ancora percepita, dal di dentro come dal di fuori, e in barba alle scartoffie amministrative, come un’entità a sé. Nel bene e — soprattutto negli ultimi anni — nel male.
Territorio che affonda le radici in una lunga storia di lavoro, resistenza, lotte operaie, antifascismo, immigrazione e fermenti culturali, oggi l’area che sorge dietro la stazione centrale è interessata da grandi trasformazioni e attraversata da complesse tensioni, che per oltre un decennio hanno trovato un naturale presidio (per alcuni) e un ideale capro espiatorio al quale attribuire ogni problema (per altri) nello spazio pubblico autogestito XM24, poi sgomberato nell’agosto del 2019. Al momento, mentre le gru e i martelli pneumatici rimodellano isolato dopo isolato il volto della zona all’insegna di una gentrificazione un po’ sgangherata, sui giornali locali e le bacheche social dei personaggi politici la cornice narrativa predominante è quella del “degrado-immigrazione-sicurezza” (per la destra) e del “decoro-normalizzazione-sicurezza” (per
Scendendo in strada, tuttavia, la sensazione è un’altra. La sensazione è che qui, dove abito ormai da quasi 15 anni, pur tra mille problemi la vera forza e la vera identità del luogo stiano proprio nella trasformazione tout court, ma non quella artificiosa imposta dall’alto quanto piuttosto quella spontanea che nasce dal basso, nel campetto di basket di Piazza dell’Unità, oltre le macerie dell’ex-XM24, tra le nuove generazioni che si ritrovano nei parchi masticando uno slang che — per ragioni d’anagrafe — faccio una gran fatica a capire. La trasformazione che s’irradia dal substrato di culture diverse e, quando è necessario, pure dal conflitto.